 Benedetta è nata in un paesino della Romagna in provincia di Forlì (1936-1964). Ha studiato alla Facoltà di Medicina di Milano. Ha avuto un privilegio che nessuno di noi avrebbe giudicato tale: Dio l’ha amata in un modo indicibile e l’ha segnata con la sua presenza crocifissa.
Benedetta è nata in un paesino della Romagna in provincia di Forlì (1936-1964). Ha studiato alla Facoltà di Medicina di Milano. Ha avuto un privilegio che nessuno di noi avrebbe giudicato tale: Dio l’ha amata in un modo indicibile e l’ha segnata con la sua presenza crocifissa.
Agli inizi è solo mal di testa; è anche una scarpa ortopedica che la bambina deve portare, sembra per i postumi di una poliomelite.
Agli inizi è l’esperienza della diversità. Il sentirsi chiamare “zoppetta” da qualche compagna. Quando la mamma viene a saperlo è la bambina che interviene: “Non dovete prendervela! In fondo dicono la verità. Sono zoppa!”
Agli inizi è non poter giocare come gli altri; non poter contare sull’agilità dell’infanzia.
Poi a 12 anni è un busto: “Stamattina ho messo per la prima volta il busto, che pianto! Mi stringe forte, forte sotto le ascelle e quasi mi leva il fiato… mi pare ora quasi di constatare di più la causa della mia disgrazia: prima ero sempre spensierata e mi credevo quasi uguale agli altri ma ora… che precipizio ci separa, non potrò mai avere le gambe uguali e se non portavo il busto forse sarei diventata gobba. Ma nella vita voglio essere come gli altri, forse più vorrei diventare qualcosa di grande. Quanti sogni, quante lacrime, quanta nostalgia, melanconica povera Benedetta”.
Verso i 16 anni è l’inizio della sordità sempre più totale… L’umiliazione è grande come il mare. Racconta a un’amica: “Spesso parlano e io mi devo accontentare di sorridere. L’unica scappatoia è quella di far credere di essere tonta e non sorda, perché – credimi – la gente ride di questa infermità… ma cosa importa? Un giorno forse non capirò più niente di quello che gli altri dicono. Ma sentirò sempre la voce della mia anima: è questa la voce che devo seguire”.
Continua a studiare instancabilmente e ad accumulare interessi: letteratura, arte, anche musica. Riesce a dare la maturità con un anno di anticipo. All’università inizia lo studio della medicina: deve sopportare umiliazioni d’ogni genere: dall’avere qualcuno che risponda per lei all’appello, all’isolamento, al trovare un professore che le getta in mezzo all’aula il libretto perché all’esame non vuole interrogarla per iscritto: “Non s’è mai visto un medico sordo”, grida.
 A 23 anni, dopo un inutile intervento chirurgico al midollo spinale, resta totalmente paralizzata agli arti inferiori, pian piano perde il senso del gusto e dell’olfatto. E non ci sono più odori e sapori di nessun genere. Poi scompare la sensibilità tattile che si concentra solo in un unico punto, la palma della mano destra: da allora in poi per comunicare con lei dovranno premere, con un alfabeto convenzionale, questa piccola “porticina” del suo essere martoriato. A 27 anni mentre sta assistendo alla Messa, durante l’elevazione, gli occhi le si riempiono di sangue e diventa completamente cieca.
A 23 anni, dopo un inutile intervento chirurgico al midollo spinale, resta totalmente paralizzata agli arti inferiori, pian piano perde il senso del gusto e dell’olfatto. E non ci sono più odori e sapori di nessun genere. Poi scompare la sensibilità tattile che si concentra solo in un unico punto, la palma della mano destra: da allora in poi per comunicare con lei dovranno premere, con un alfabeto convenzionale, questa piccola “porticina” del suo essere martoriato. A 27 anni mentre sta assistendo alla Messa, durante l’elevazione, gli occhi le si riempiono di sangue e diventa completamente cieca.
Così scrive in una lettera alla mamma nel 1959: “Da quando so che c’è Chi mi guarda lottare cerco di farmi forte…. Io credo all’Amore disceso dal cielo, a Gesù Cristo e alla sua croce gloriosa, sì, io credo all’amore… Tu mi dirai che io in Gesù ci sono nata! Sì, ma prima lo sentivo lontano! Ora invece so che Dio è dappertutto… Ormai con me c’è Dio e sto bene…. Sono cieca, sorda e quasi muta… Ma io dico… In principio era la Luce e la Luce era la vita degli uomini…. Le mie giornate sono lunghe e faticose, però ugualmente dolci e con la luce di Dio”.
Attorno al letto di Benedetta scorre una vita difficilmente immaginabile: a volte nella sua camera sono più di quindici ragazzi e ragazze che tentano faticosamente di comunicare con lei, con quel lungo di paziente alfabeto muto, mentre Benedetta si rende conto di tutti e di tutto, “interessandosi di tutti e di ognuno”.
Il giorno prima della sua morte, Benedetta chiamò la mamma e le disse: “Mamma, mettiti in ginocchio e ringrazia Dio per me per tutto quello che mi ha dato”. Muore a soli 27 anni.
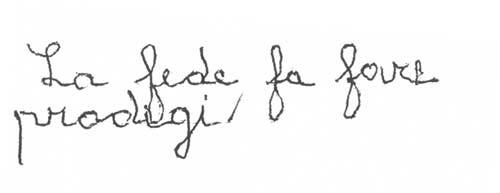 Scriveva Benedetta a una sua amica: “Ora nel salutarti ti ripeto che ho bisogno, per vivere, di sentire che Dio vive in me”. Era questa la verità della sua “leggenda”. Ma è anche la verità della nostra “leggenda”. Noi però ricordiamo abbastanza che per vivere dobbiamo “sentirLo vivere in noi”, e che, per sentirLo vivere in noi, dobbiamo darGli tutto?
Scriveva Benedetta a una sua amica: “Ora nel salutarti ti ripeto che ho bisogno, per vivere, di sentire che Dio vive in me”. Era questa la verità della sua “leggenda”. Ma è anche la verità della nostra “leggenda”. Noi però ricordiamo abbastanza che per vivere dobbiamo “sentirLo vivere in noi”, e che, per sentirLo vivere in noi, dobbiamo darGli tutto?
(A. Sicari – Ritratto di Santi, pp 165-177)
